In occasione dei 1700 anni dal Concilio di Nicea, la Rete teologica ‘Santi Angeli’ ha dedicato l’incontro di lunedì 10 marzo a un dialogo sulla professione di fede stabilita in quel Concilio.
Ecco una sintesi della serata teologica.
L’antefatto: in cerca dell’unità
Se una distanza di millesettecento anni ci separa dal concilio di Nicea, resta vero che Nicea diventa nostra nella Messa di ogni domenica con la professione di fede proclamata nel Credo: “…Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre pima di tutti i secoli… generato non creato, della stessa sostanza del Padre…”.
Non ci scandalizzi il fatto che il Concilio di Nicea sia voluto da Costantino imperatore d’Oriente e d’Occidente dopo la vittoria su Massenzio nel 313. Dopo quasi tre secoli di diffidenza e di persecuzione, il cristianesimo - insieme con tutte le altre forme religiose - viene riconosciuto come ‘religio licita’ da Costantino, che vuole unificare l’impero anche con il contributo dei cristiani. Peccato che questi appaiano divisi sul punto centrale della loro fede. Tutti credono che Gesù Cristo possieda una ‘forma divina’, ma molti non lo riconoscono come Dio. Un grave conflitto scoppia in Alessandria d‘Egitto, città in cui si concentrano i filosofi e gli intellettuali eredi dell’antica Grecia. Ario, prete di Alessandria, facondo predicatore e poeta, incanta vescovi e popolo con i suoi sermoni e le sue canzoni annunciando Gesù figlio di Dio ma non Dio lui stesso. Il contrasto con il suo vescovo Alessandro è vivissimo e si propaga per vaste zone dell’impero. La convocazione di un concilio generale – che noi chiameremmo ‘ecumenico’ - diventa necessaria. I vescovi provengono in massima parte dall’Oriente; dall’Occidente arrivano anche due vescovi in rappresentanza del papa, cagionevole di salute. Costantino mette a disposizione il sistema di posta imperiale e la residenza nel suo palazzo. A Nicea gli storici stimano una presenza di 150-200 vescovi, anche la tradizione riconosce la cifra simbolica di 318, come i servi di Abramo. Non possediamo la cronaca delle sessioni del concilio ma solo le formule conclusive, relative ai temi trattati: l’identità di Gesù, la data della Pasqua, questioni disciplinari.
Il fatto: il Concilio di Nicea, Gesù Cristo è Dio
I vescovi riuniti a Nicea vogliono professare la divinità di Gesù Cristo secondo l’evangelista Giovanni che afferma all’inizio del Vangelo: ‘In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio’. Occorre mettere al riparo questa fede dalle interpretazioni riduttive: gli ariani dicono che il Figlio non è Dio, ma la prima e più eletta creatura, intermediario tra il Padre e gli uomini; i monarchiani affermano che Padre e Figlio costituiscono un’unica persona. Per affermare la fede di sempre, Nicea impiega un nuovo linguaggio, già parzialmente in uso presso alcune chiese dell’Oriente: il Figlio è ‘generato dal Padre come unigenito, cioè della stessa sostanza del Padre. Le parole chiave - ousìa-natura; omoùsios-della stessa sostanza – sono tratte dalla filosofia greca. Con questa preziosa innovazione si giunge a precisare che il Figlio è allo stesso livello del Padre, Dio come il Padre: Dio vero da Dio vero, generato non creato, consustanziale al Padre, per mezzo del quale sono state create tutte le cose in cielo e in terra. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: Io e il Padre siamo una cosa sola. Nicea afferma la stessa cosa con il linguaggio del tempo che verrà ulteriormente chiarito nel concilio di Costantinopoli con l’impiego di un’altra parola: hypostasis-persona. Si chiarirà così che Dio è uno solo - una sola natura divina - in tre persone divine: Unità e Trinità di Dio.
Dopo Nicea: un contributo fondamentale alla fede cristiana
Un lungo travaglio segue il Concilio di Nicea. L’arianesimo continua a pervadere molta parte dell’universo cristiano, popolo e vescovi. I barbari che entrano nell’impero romano diventano cristiani attraverso l’arianesimo, più corrispondente alla loro cultura. Atanasio, divenuto vescovo di Alessandria e grande difensore di Nicea, viene più volte esiliato. Dopo Nicea seguono due altri grandi concili: Costantinopoli nel 381, dove viene affermata la divinità dello Spirito Santo, terza persona della Trinità; Calcedonia nel 431 che dichiara Maria theotòkos-madre di Dio, riaffermando la divinità della persona del Figlio di Dio divenuto uomo.
Nei secoli successivi, con l’espansione del cristianesimo in altre culture, particolarmente in Cina e in altre regioni dell’Asia e in Africa, si pone la domanda: come la fede cristiana, dichiarata nei Vangeli e in tutto il Nuovo Testamento e poi chiarita a Nicea e negli altri concili con il contributo della cultura greca, potrà venire espressa e ulteriormente approfondita in culture diverse? E anche: come possiamo riesprimerla noi – senza rinnegarla o ridurla – nella cultura e nel linguaggio odierni?
La fede dei semplici e dell’intero popolo cristiano rimane il punto di paragone e la perenne garanzia per tutti i popoli e tutti i linguaggi. Solo perché si crede con la vita si giunge a esprimere la fede con parole vere e appropriate.
Don Angelo Busetto
UN NUOVO ARIANESIMO?
Occuparsi del Concilio di Nicea è importante non solo dal punto di vista storico. La sua confessione cristologica conserva anche e precisamente oggi la sua permanente attualità, sia nella situazione ecumenica sia all’interno della nostra Chiesa, dove lo spirito di Ario è tornato ad essere molto presente e dove è osservabile un forte risveglio delle tendenze ariane. Già negli anni ‘90, il cardinale Joseph Ratzinger ravvisava la vera sfida del cristianesimo contemporaneo in un “nuovo arianesimo” o, quantomeno, in un “nuovo nestorianesimo, abbastanza pronunciato”. Tali tendenze ariane si manifestano soprattutto nel fatto che diverse persone, persino tra i cristiani, sono sensibili a tutti gli aspetti dell’umanità di Gesù di Nazaret, ma hanno difficoltà nell’accogliere in pieno la fede cristologica della Chiesa, in quanto vedono come problematico il credo secondo cui questo Gesù è l’unigenito Figlio di Dio, presente in mezzo a noi come il Risorto. Anche nella Chiesa spesso non si riesce più a scorgere oggi il volto del Figlio di Dio nell’uomo Gesù.
Dalla dichiarazione del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, 2022
UNA QUESTIONE DI VITA
Un libro uscito nel 1974, letto quando avevo poco più di 20 anni e pure oggetto di lavoro comune, aveva questo titolo:
Alessandro e Ario, Un esempio di conflitto tra fede e ideologia. Documenti della prima controversia ariana, a cura di Enzo Bellini, Jaca Book.
Sotto il titolo si legge: I documenti di una controversia che coinvolse tutta la Chiesa dall'inizio del secolo IV rivelano i dati essenziali di due modi diversi di accostare il fatto cristiano: quello di chi lo costringe entro i limiti di una ideologia e quello di chi ne riconosce la trascendenza. Questi due modi riaffiorano in ogni epoca, per cui la meditazione della vicenda antica aiuta a rispondere oggi.
La controversia di Ario e del vescovo Alessandro dunque mette in evidenza come ci siano due modi di intendere il cristianesimo: o è l’irrompere del Mistero di Cristo nella storia, nella mia storia, qualcosa che continuamente mi supera, oppure è una mia idea, su Dio, sul mondo, sulla vita, alla quale piego il fatto cristiano. A Nicea si sono scontrate queste due posizioni, che si ripropongono sempre nel corso della storia. Negli anni in cui avevo riscoperto il cristianesimo, ci chiedevamo cos’era per noi essere cristiani. Una domanda alla quale non si è mai finito di rispondere. Una domanda che accompagna tutta la vita.
Ecco come si esprimono alcuni amici dopo la serata sul Concilio di Nicea:
+ L'incontro sul concilio di Nicea, come gli incontri precedenti, alimentano il mio bisogno di Dio e conseguentemente il bisogno di conoscerLo per rendere sempre più penetrabile il Mistero. Mi educa ad accettare la mia impotenza, lo stato di Sua "creatura". Ad accettare la strada che mi viene indicata da percorrere, con le mie gambe, con l'aiuto dei compagni di strada, con il Suo aiuto. Alle volte il percorso si complica... G.F.
+ È bello ascoltare insieme parole di vita eterna. R.V,
+ Se Gesù non fosse Dio, non mi sentirei capita, amata, e accompagnata ogni singolo istante. Mi mancherebbe la dimensione dell’eternità, e la vita sarebbe un susseguirsi di fatti più o meno sensati, più o meno lieti o tristi. Tutto si dissolverebbe nel nulla. La dimensione della Speranza verrebbe a mancare. Aldilà delle dispute teologiche, io vivo così Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. A.R.
Mario Frizziero
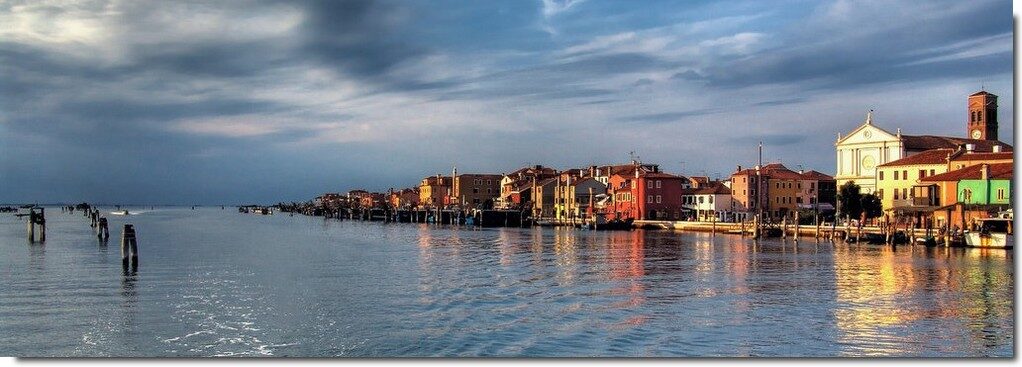
 Anche qui da noi alcune donne hanno cominciato ad ascoltarlo e a comunicarlo ai figli, piccoli e già fioriti. Con timore e tremore e con l’audacia della fede accettano la sfida di raccontarsi davanti a tante persone: “Cristo ti accoglie nel sacramento così ‘difficile’ della confessione, ti invita nella comunità riunita per l’Eucaristia, ti rimette in cammino in uno slancio di vita… E’ il sentore di una felicità nuova, che sgorga dal profondo”. Le parole escono come un torrente: “Mi spiazza davvero con quale semplicità i bambini si fanno coinvolgere. Mi sono chiesta: perché, se la cosa li rende felci, non fare come i bambini?”. “I sacramenti non hanno avuto un significato preciso nella mia vita al tempo in cui li ho ricevuti, ma continuano ad agire in me da allora in poi. Accade in maniera improvvisa, illuminante, accecante. Tutto appare più chiaro, mi pare di percepire il senso di tutto, come quando riesci a vedere un pezzo di intreccio dietro al tessuto. Ho sempre avuto la percezione che qualcosa di molto più grande ci fosse dietro le cose di cui io riuscivo a comprendere solo un pezzettino”. “Voglio dare ai miei figli la possibilità di accogliere - magari più e meglio di me - la grazia, il dono più grande, più forte di tutto, il senso più alto di quello che vivono. Come un seme che poi loro potranno sviluppare o no. Ma con i sacramenti che ricevono non saranno mai soli”. Vale per la vita intera: c’è chi racconta la consolazione del sacramento dell’unzione nel corso di una malattia ormai superata. In mezzo al nostro mondo vario e terribile, nelle paure che ci piovono addosso come malefici droni, ci ritroviamo come quando, circondati dalla gente in una strada sconosciuta di una grande città, scorgiamo in un lampo un volto amico e la segnalazione di una guida; finalmente gli occhi si illuminano e i polmoni respirano. Lo percepiamo nella canzone di Fabrizio Moro, proposta dal vivo mentre sullo schermo scorrono le parole e appare il volto di Gesù: “Tu che sei il sogno più grande / Tra i sogni più veri / E questa canzone / Che gira e rigira, la dedico a te / Il mio unico amore / Il senso di ogni cosa che c'è / Che sei l'infinito tra i miei desideri”. L’infinito che colma i desideri è Gesù che viene a incontrarci, non solo come ascoltatori della sua Parola, ma testimoni della sua Presenza, nuovi protagonisti in una comunità ricca di storia, toccata dal balenare di un guizzo di trasfigurazione.
Anche qui da noi alcune donne hanno cominciato ad ascoltarlo e a comunicarlo ai figli, piccoli e già fioriti. Con timore e tremore e con l’audacia della fede accettano la sfida di raccontarsi davanti a tante persone: “Cristo ti accoglie nel sacramento così ‘difficile’ della confessione, ti invita nella comunità riunita per l’Eucaristia, ti rimette in cammino in uno slancio di vita… E’ il sentore di una felicità nuova, che sgorga dal profondo”. Le parole escono come un torrente: “Mi spiazza davvero con quale semplicità i bambini si fanno coinvolgere. Mi sono chiesta: perché, se la cosa li rende felci, non fare come i bambini?”. “I sacramenti non hanno avuto un significato preciso nella mia vita al tempo in cui li ho ricevuti, ma continuano ad agire in me da allora in poi. Accade in maniera improvvisa, illuminante, accecante. Tutto appare più chiaro, mi pare di percepire il senso di tutto, come quando riesci a vedere un pezzo di intreccio dietro al tessuto. Ho sempre avuto la percezione che qualcosa di molto più grande ci fosse dietro le cose di cui io riuscivo a comprendere solo un pezzettino”. “Voglio dare ai miei figli la possibilità di accogliere - magari più e meglio di me - la grazia, il dono più grande, più forte di tutto, il senso più alto di quello che vivono. Come un seme che poi loro potranno sviluppare o no. Ma con i sacramenti che ricevono non saranno mai soli”. Vale per la vita intera: c’è chi racconta la consolazione del sacramento dell’unzione nel corso di una malattia ormai superata. In mezzo al nostro mondo vario e terribile, nelle paure che ci piovono addosso come malefici droni, ci ritroviamo come quando, circondati dalla gente in una strada sconosciuta di una grande città, scorgiamo in un lampo un volto amico e la segnalazione di una guida; finalmente gli occhi si illuminano e i polmoni respirano. Lo percepiamo nella canzone di Fabrizio Moro, proposta dal vivo mentre sullo schermo scorrono le parole e appare il volto di Gesù: “Tu che sei il sogno più grande / Tra i sogni più veri / E questa canzone / Che gira e rigira, la dedico a te / Il mio unico amore / Il senso di ogni cosa che c'è / Che sei l'infinito tra i miei desideri”. L’infinito che colma i desideri è Gesù che viene a incontrarci, non solo come ascoltatori della sua Parola, ma testimoni della sua Presenza, nuovi protagonisti in una comunità ricca di storia, toccata dal balenare di un guizzo di trasfigurazione.